Una piccola premessa sull’epifania di questo libro. Lo possiedo da tempo, affiorato e scomparso a intervalli regolari negli scaffali della libreria. Appartiene a una tiratura fuori stampa di Einaudi, un regalo ai lettori distribuito in ventimila copie una quindicina di anni fa. Sono una dei ventimila destinatari; se mi ha raggiunta non è stato per caso. L’intuito mi ha sempre suggerito che prima o poi quelle pagine avrebbero parlato compiutamente a un’altra me e, dunque, non dovevo separarmene. L’idea della veggenza in poesia mi affascinava già allora ma ancora mi sfuggiva come quel messaggio potesse saldarsi sul mio percorso. O meglio, il percorso era stato appena intrapreso tanto che non potevo neppure capire dove mi trovassi. Ma proprio per le cadenze sottili e inesorabili che la vita silenziosamente ci riserva, eccolo ora reclamare le mie attenzioni. E io subito gliele ho accordate, bevendo ogni sorso, sicura che nulla avrei sprecato di quel calice.
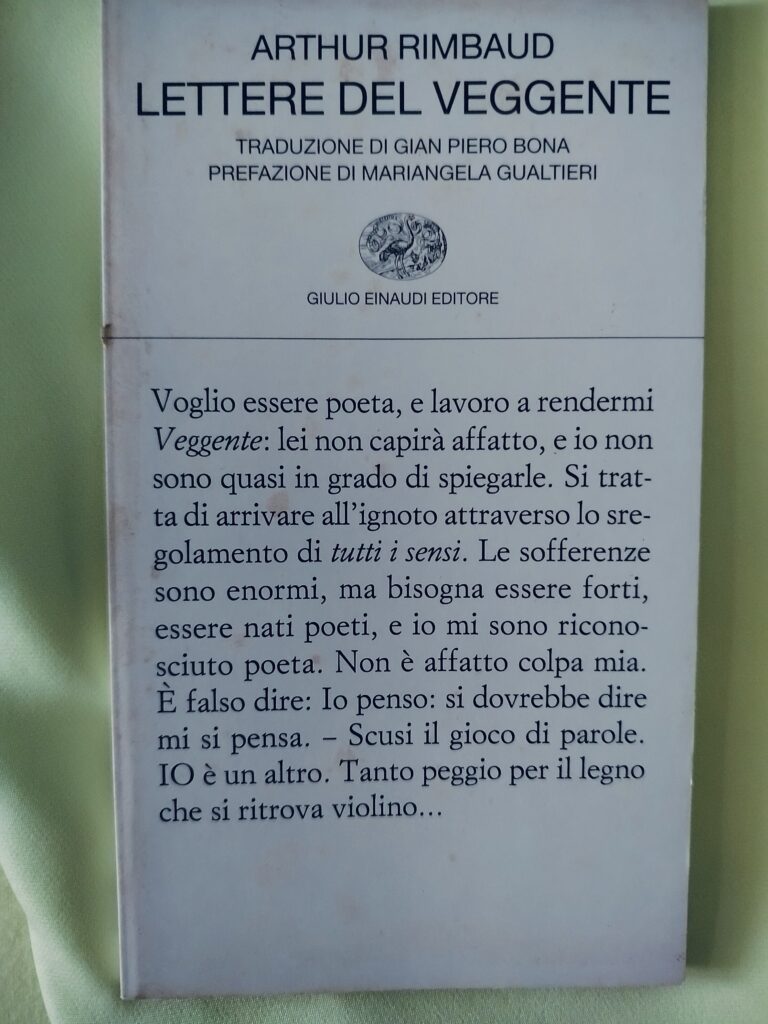
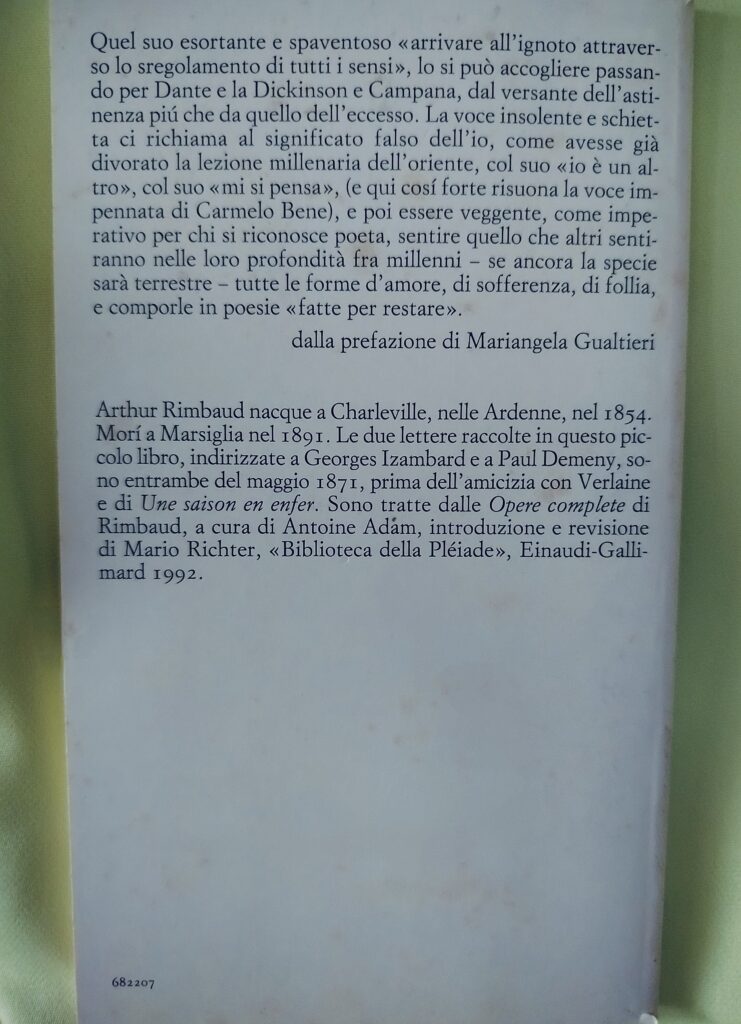
Così mentre impacchettavo dei libri per il book-crossing ospedaliero, mi è tornato fra le mani. “Aprimi! Sono medicina”. Vero, la poesia lo è senz’altro, anzi preferirei dire medicamento, vocabolo più desueto che meglio sembra trattenere la sostanza curatrice. E poi, sì, fa diventare anche veggenti se davvero lo vogliamo. Parola di Arthur Rimbaud, che quando vergava queste frasi aveva appena diciassette anni. Erano i giorni della Comune di Parigi e il giovane scalpitava per salire sulle barricate. I destinatari delle sue confessioni sono Georges Izambard, insegnante di retorica, e Paul Demeny, poeta. Le sponde offerte dai due interlocutori favoriscono l’invettiva contro la cultura morta dell’erudizione, l’apostrofe rivolta allo studioso da scrivania che dimentica il mondo ma ha la pretesa di spiegarlo. Chi compila dizionari è un accademico, dunque un fossile, mentre il poeta percepisce tutto, tocca la parola viva in cui è depositato ogni sentire, perciò suo compito è definire l’ignoto che si risveglia, far stillare resina e sangue dall’anima universale. «Tutta la poesia antica porta alla poesia greca. Vita armoniosa. […] In Grecia, dicevo, i versi e le lire ritmano l’azione. Dopo, musica e rime sono giochi, divertimenti. Lo studio di quel passato affascina i curiosi: molti si divertono a rinnovare queste cose antiche: è roba per loro. L’intelligenza universale ha sempre gettato via le sue idee, naturalmente; gli uomini raccattavano una parte di questi frutti del cervello: agivano con loro, ci scrivevano dei libri: così andavano le cose, poiché l’uomo non curava se stesso, non si era ancora risvegliato, o non era ancora nella pienezza del grande sogno. Funzionari, scrittori: autore, creatore, poeta, quest’uomo non è mai esistito! Il primo studio dell’uomo che vuole essere poeta è la conoscenza di se stesso, intera: egli cerca la sua anima, la scruta, la mette alla prova, la impara».
Ma come avviene una tale immersione, questo inabissarsi senza ritorno? Non è un atto pensato, si tratta piuttosto di un divenire. Farsi veggenti è una condizione non una decisione. D’altra parte, essere fino in fondo comporta una discesa all’inferno come il farmaco che cura è anche veleno. Evitando l’esperienza straniante e dolorosa, nulla accade. Non c’è creazione né guarigione. Si resta a un grado frammentato e incosciente, che preclude qualsiasi capacità sensitiva, nascosti al vero sé. Allora e solo allora «queste poesie saranno fatte per restare. In fondo sarebbe ancora un po’ la poesia greca». Poesia come sguardo lucido gettato sull’ignoto, questo per Rimbaud è il coraggio della precognizione, risanamento della ferita che ha separato l’uomo dalla scintilla divina. Non a caso il cantore e l’autore di versi erano considerati dagli antichi prossimi ai profeti, alle personalità in grado di formulare la parola del Dio attraverso gli oracoli. Una caratteristica basata sullo “sregolamento di tutti i sensi” che, nei termini espressi dal poeta francese, ricorda da vicino la possessione di indovini, Sibille e altre figure sacre. Un livello di penetrazione e limipidezza intuitiva scomparsi dalla storia del pensiero umano e dai modi di comunicare, con particolare riferimento al dire poetico, per tornare in auge con il romanticismo. A questo proposito sarà utile la Theophania di Walter Friedrich Otto per aiutarci a navigare fra sentimento e interpretazione dell’antico. Il divino era per i nostri predecessori realtà esperita, non un’astrazione bensì un fatto, una presenza reale che aveva determinato veri accadimenti, cosicché il culto e il mito non erano a loro volta semplici rappresentazioni ma emanazioni in cui il fatto riviveva. Allo stesso modo la poesia lirica greca rispecchiava un’esperienza non filtrata in cui la natura e il tempo vissuto si riversavano senza disperdere il loro carico emotivo che il poeta, come medium fra la terra e le cose celesti, raccoglieva con sensibilità limpida e profetizzante. Fu questo il primo genere letterario a far presa fra gli Elleni, in assenza di un sistema espressivo codificato, precedentemente e diversamente dall’epica con cui non smetterà di confrontarsi, soprattutto nel mezzo dei profondi mutamenti politici e sociali a chiusura dell’VIII secolo a. C. Un’apparizione, lo si è detto, che si confonde con le voci degli oracoli e con i primi oscuri autori dei cosiddetti nòmoi, componimenti pure a tema religioso, dei quali nulla resta.
Rimbaud teorizza un nuovo avvento in cui essere e sentire siano interi e saldati. Qui sgorgherà la parola pura tratta dall’anima universale. Qui si attingerà alla pienezza del grande sogno, quale forma concreta di ogni immaginazione. Il tono è perentorio, perché chi è destinato non accampi scuse: «Dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi. Tutte le forme d’amore, di sofferenza, di follia; egli cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni per conservarne solo le quintessenze. […] Poiché egli arriva all’ignoto! Avendo coltivato la sua anima, già ricca, più di chiunque altro! Egli arriva all’ignoto, e anche se, sgomento, finisse col perdere la comprensione delle sue visioni, le ha viste».
Il poeta è uno che ha visto, con una capacità visiva che ha squassato tutti i sensi. Dunque sa. E il suo sapere porta nel mondo il respiro abissale ed estremo dei reami sommersi in cui occultamente si è inoltrato.
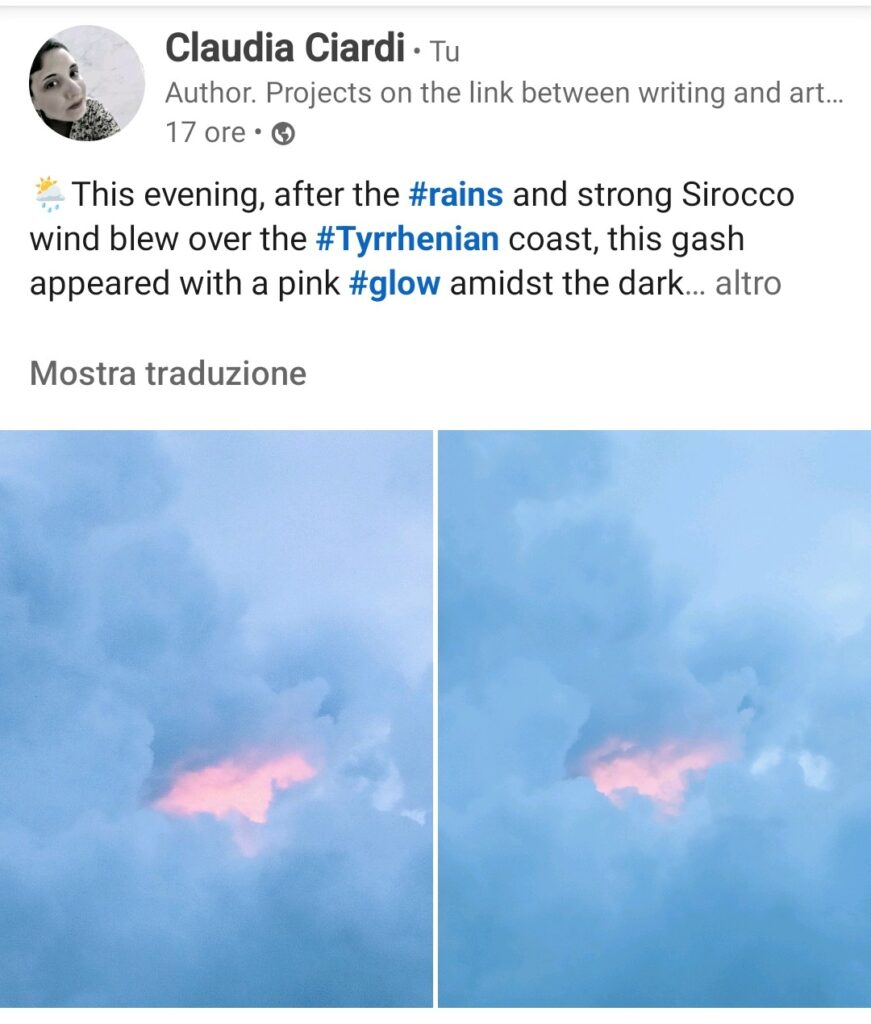

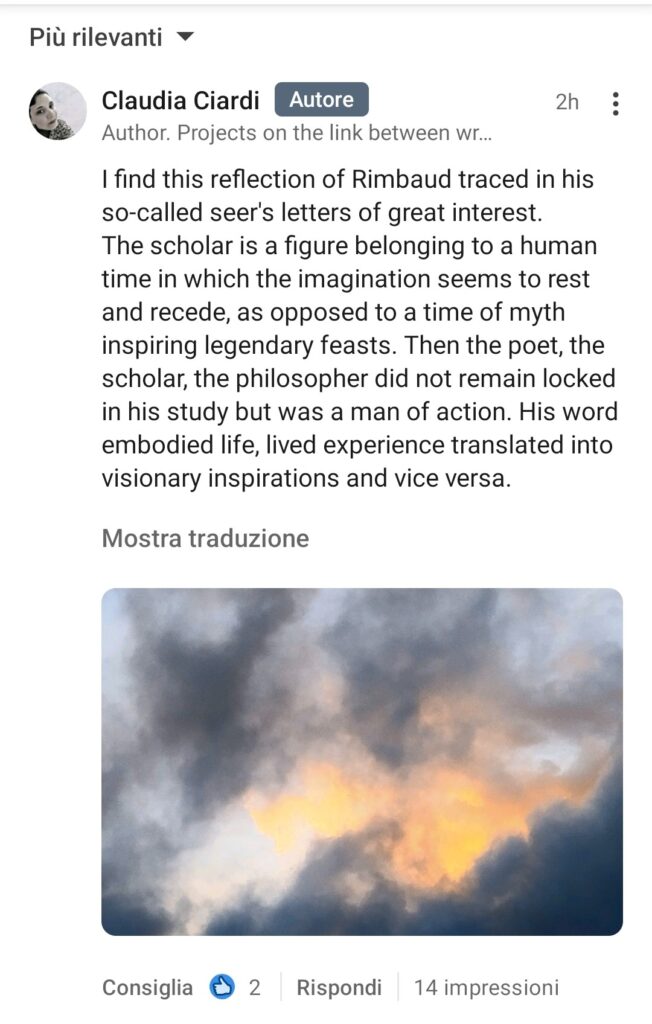
Nefomanzia – A pink glow amidst the dark
* Una precisazione per chi cerca i miei libri nello Store online di Mondadori. In seguito all’aggiornamento del sito, la rete si indirizza alternativamente a un link corretto e uno errato; quest’ultimo non permette la visualizzazione dei titoli acquistabili sotto il mio nome. Segnalo pertanto il collegamento corretto a chiunque voglia raggiungermi, auspicando che gestori e motori di ricerca risolvano il problema.
https://www.mondadoristore.it/claudia-ciardi/c/05308508
* Link ai post tematici su youtube – Canale “margini e miraggi”
* Alcuni dei temi trattati in questo articolo sono alla base della mia raccolta poetica d’esordio:
Claudia Ciardi, Umana Sibilla, con una prefazione di Daniele Regis, Setart Edizioni, aprile 2025
![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)